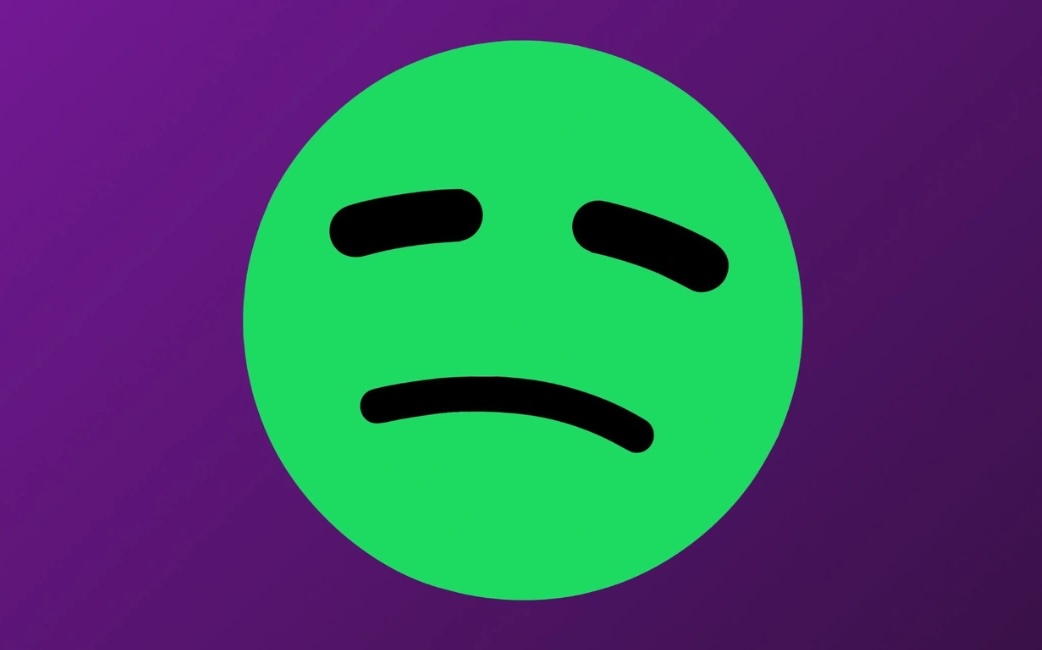
È ora di ripensare il mercato dello streaming musicale
Dicembre: tempo di Spotify Wrapped, e quindi, per noi, di polemizzare su un sistema che ha sempre più ombre che luci.
Premessa doverosa: non è solo Spotify il problema. Tuttavia qui ci concentreremo su Spotify, per una questione di monopolio del mercato, il che è abbondantemente provato in questi giorni in cui le stories di IG pullulano di classifiche – tutte diverse, tutte un po’ uguali.
chi monetizza dagli streaming? Spoiler: non l* artist*.
Mentre il fatturato di Spotify continua ad aumentare, non aumentano di pari passo i proventi destinati a chi, per far musica, si fa un mazzo così. L’ultima trovata del colosso svedere, in questo senso, è un nuova politica entrata in vigore nell’aprile ’24, che ritocca il metodo di calcolo delle royalties.
Un brano, sostanzialmente, per rientrare nel calcolo delle royalties (e quindi generare profitto), deve aver ottenuto almeno 1000 ascolti negli ultimi dodici mesi (qui la fonte). Una misura che va a colpire direttamente tutta quella fetta di “creators” che genera numeri piccoli, che già prima intascava briciole. E che ora invece si trova a zero monetizzazione dalla propria musica. Si parla di decine di milioni di canzoni.
Quanto vale la musica?
Questa simpatica trovata è stata presentata come uno strumento a difesa di “artisti professionisti ed emergenti”, e Spotify dichiara di non intascare nulla di quei soldi risparmiati (circa 40 milioni di dollari nel 2024) ma di averli redistribuiti tra gli aventi diritto. Peccato che la monetizzazione effettiva non sia cresciuta sostanzialmente nello scorso anno. Un singolo ascolto “vale” ancora circa 0.004 dollari, e se fai musica puoi permetterti un caffè al bar ogni 300 streams circa. Tra l’altro, Spotify è ancora una delle piattaforme che paga meno l* artist* per singolo stream.
C’è questo sito, Spotify Unwrapped, che permette di calcolare (in base al tuo tipo di abbonamento e ai minuti effettivi di ascolto) quanti soldi sono stati effettivamente intascati dall* artist* grazie ai tuoi streams. Chi scrive, ad esempio, ha fatto guadagnare al proprio cantautore più ascoltato circa 30 centesimi di euro in un anno, su 419 minuti di ascolto.
Questo spiega in parte il fatto che l* artist* (emergent* ma non solo) raramente possano permettersi di fare della propria musica l’unica fonte di sostentamento diretta. E spiega anche come mai il costo dei biglietti dei concerti e del merchandising stia aumentando negli anni. Perché dalla fruizione della propria arte non si guadagna una lira, oggi che il mercato dei supporti fisici è più basso che mai. E chi fa musica non ha ancora imparato a cibarsi di quella musica. Anche se sarebbe bello.
Quanto costa la musica?
Daniel Ek, CEO di Spotify, che è evidentemente un buontempone, qualche tempo fa ha affermato che “fare musica ad oggi ha un costo quasi nullo”. Lui, a dirla tutta, usa più spesso il termine “content”, contenuto, al posto di “musica”. Il fatto che quella musica di cui parla abbia sempre meno contenuto è un’altra faccenda, collegata alla prima, ma che per il momento lasceremo perdere. Altrimenti non ci fermiamo più.
L’affermazione di Ek sarebbe anche divertente se non ci fosse un intero settore di lavoratori e lavoratrici che la musica la fa davvero. Con strumenti, microfoni, sintetizzatori, computer, con le mani e con la testa, investendo un sacco di tempo e un sacco di soldi. Una categoria enorme e varia, che si deve reinventare di continuo per pagare le bollette a fine mese e potersi permettere di far coincidere in qualche modo, in qualche misura, il proprio lavoro e la propria passione.
Perché la realtà è questa, tralasciando per un attimo i grandi player dell’industria discografica (che comunque non trovano nello streaming la fonte di guadagno principale). Per tutt* l* altr*, il mercato naviga sempre più nell’incertezza, tra algoritmi a volte poco meritocratici e sicuramente poco trasparenti, ascoltator* sempre più disabituati ad approfondire, social che sono spesso l’unico strumento che emergent* hanno per provare a emergere davvero, ma che -lo diciamo?- assomigliano sempre più a una discarica di stimoli buttati lì a distrarci, a rimbambirci, a farci marcire il cervello.
Ma d’altronde, di tutto questo, a Daniel Ek (e all’intero sistema che egli inevitabilmente rappresenta) non frega nulla. Anzi: l’intera baracca si basa sul fatto che la qualità della musica sia bassa, dimenticabile, scrollabile via. E sul fatto che il numero di nuovi brani caricati sui server di Spotify sia in continuo aumento. Se poi le canzoni non dovessero raggiungere i famosi mille streaming annuali, poco male.
Intanto Ek è ufficialmente più ricco di qualunque artista della storia della musica, ed ha guadagnato, nel solo 2024, ben 345 milioni da Spotify. Se fosse stato un artista (e per sua fortuna non lo è) avrebbe avuto bisogno di circa 115 miliardi di streams (in un anno!) per ottenere la stessa quantità di soldi. Per farvi un’idea: i due artisti più ascoltati su Spotify, ovvero Taylor Swift e Drake, hanno un totale di circa 92 miliardi e 80 miliardi, rispettivamente. Ma nella loro intera carriera, non in un anno.
Serve altro per pensare ad altro?
Probabilmente no, però ci sarebbero altri discorsi, che per ragioni di spazio affronteremo solo brevemente.
Innanzitutto, c’è la questione (già ampiamente dibattuta) sul possesso della musica che ascoltiamo. Il concetto stesso di streaming si basa sull’idea di fornire un servizio in prestito momentaneo. Di fatto, quando smetteremo di pagare la subscription, o disinstalleremo l’app, tutta la nostra musica preferita non sarà più a nostra disposizione.
Il castello di carte si regge su tre aspetti: sull’inconsapevolezza (dei fruitori del servizio, ma molto spesso anche di chi la musica la fa), sulla comodità (di avere un enorme archivio di musica accessibile ad un prezzo relativamente basso), e sui grandi numeri (Spotify è arrivato a 246 milioni di iscritti nel 2024).
E a proposito di numeri e di inconsapevolezza: come ha eccellentemente espresso Bassi Maestro sul suo Instagram, lo Spotify Wrapped è l’emblema di tutto questo. È pubblicità gratuita e volontaria che l’ascoltatore fa alla piattaforma, e che mette al centro i numeri come unico idolo e unica forma di realizzazione delle proprie aspirazioni artistiche. E infatti poi artist* (sia affermat* che emergent*) ricorrono a playlist con ascolti bot per gonfiare i propri numeri e poi flexarli sui social. Ma che storia è?
(Poi va be’, ci sarebbe anche quella robina degli investimenti di Daniel Ek nell’industria bellica, ma questa la lasciamo a chi vuole approfondire. Fonti qui e qui.)
ma allora: Può esistere un sistema di streaming equo? etico?
Riassumendo: magari sì, ma finora no. Molt* artist* hanno provato negli anni a muoversi in diversi modi contro lo streaming in generale, e contro il monopolio di Spotify. Ma la realtà è che la leva di cui dispongono l* artist* è nella maggior parte dei casi nulla rispetto a quella dei colossi dell’industria.
Chi aspira a far musica, o cerca di emergere, si tirerebbe la proverbiale zappa sui piedi a decidere di non pubblicare la propria roba su Spotify: è troppo grande la fetta di pubblico che perderebbe. E se vi sembra che l’intero sistema assomigli ad un ricatto, è perché lo è. Come uscirne? Bisogna ripensare il mercato: non è semplice, ma le alternative esistono già.
Le alternative allo streaming
Bandcamp è un ibrido, a metà tra piattaforma di streaming e marketplace digitale, che permette a chi ascolta di supportare direttamente i creators. Non prevede abbonamento per l’utente né costi per la distribuzione dell’audio. Dopo un certo numero di ascolti (decisi dall* artist*), scatta l’obbligo di acquisto del brano o dell’album (ad un costo anch’esso deciso dall* artist*, che può essere gratuito). Dopodiché, la canzone potrà essere ascoltata illimitatamente in streaming sulla piattaforma, oppure scaricata ed ascoltata offline su qualunque dispositivo. Bandcamp si tiene tra il 10 e il 15 percento delle transazioni. I suoi algoritmi che propongono nuova musica in base agli ascolti personalizzati sono molto apprezzati tra gli addetti ai lavori.
Per chi si sente ancora più radicale, poi, c’è Funkwhale. È una “community-driven social platform”, basata su server libero e open source, no-profit, decentralizzato e aperto. Chiunque può aprirvi un proprio server, autogestirlo, e utilizzarlo come spazio di condivisione e ascolto di musica e podcast.
Gestita da volontar* e attivist*, la piattaforma ha come scopo quello di rendere la musica fruibile a tutt*, gratuitamente. Questo non significa che la propria musica non abbia valore, anche monetario, anzi: vuol dire riprenderne il possesso. Impedire a un tech bro multimilionario di sfruttare la musica che facciamo per arricchirsi ancora di più è una precisa scelta politica. Sulla propria pagina, poi, l* artist* possono inserire i link ai propri store: basta un solo acquisto da parte di un fan “reale” per superare di gran lunga le paghe da sfruttamento di Spotify e compagnia bella.
Insomma: le alternative esistono già. Bisogna solo popolarle, con consapevolezza e rispetto, ricordandoci che tutto ciò che è troppo comodo nasconde per forza, da qualche parte, una parte lesa.
VUOI SCOPRIRE (E SOPRATTUTTO, SOSTENERE SUL SERIO) ALTRA MUSICA BELLISSIMA E FARE POLEMICA? LEGGI FELT E SEGUICI SU INSTAGRAM!

